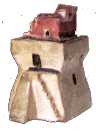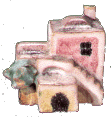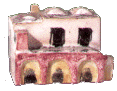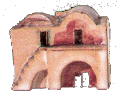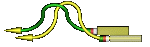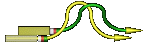e il labirinto del presepe
L'immagine simbolica principale del presepe è ovviamente la Natività. Ma a questa se ne aggiunge un'altra, altrettanto centrale, quella del Viaggio, che indica la periodica necessità di un mutamento di stato. Il viaggio dei pastori ha la struttura di una iniziazione e comprende e unifica nel suo percorso un complesso di simboli arcaici sempre presenti nel presepe: la grotta, la montagna, l'acqua, il fuoco, il pozzo, il ponte, la fontana, il forno, la scala, il mulino, l'abitato. Quasi tutti questi luoghi sono antichissimi simboli di religiosità arcaica. Indicano il passaggio dai vivi ai morti (la grotta, il pozzo, il ponte, il fiume, la scala); i luoghi dell'epifania divina (la grotta, la montagna), il tramite dall'indistinto al distinto, dal caos alla cultura (l'acqua, il ponte, il mulino), la continua lotta per salvare la cultura dall'attacco della natura, ostile pur se fruttifera (l'abitato, la grotta, le recinzioni). Soprattutto la grotta è centrale nel simbolismo del presepe. Essa, in quanto tramite precipuo del rapporto tra vivi e morti ha anche valenze pericolose, che appunto Gesù riesce ad eliminare. Nel Vangelo apocrifo Pseudo-Matteo, si racconta: "Giunti ad una grotta, decisero di riposare sotto di essa, e Maria scese dalla giumenta e si sedette, tenendo in grembo Gesù. Ora c'erano tre ragazzi che facevano il viaggio con Giuseppe e una ragazza con Maria. Ed ecco all'improvviso uscirono dalla grotta molti draghi, vedendo i quali i ragazzi si misero a gridare per il grande spavento. Allora Gesù, sceso dal grembo di sua madre, si fermò ritto in piedi di fronte ai draghi, e quelli lo adorarono, e dopo averlo adorato si allontanarono da loro". La grotta dunque è anche la porta degli Inferi, dell'indifferenziato, del mostruoso. E' significativo che secondo la tradizione popolare chi nasce la notte di Natale è un lupo mannaro. In un momento gravido di incertezze, nella "pausa cosmica" della notte in cui finisce il vecchio ciclo dell'anno e inizia il nuovo, la grotta, passaggio dal sotto al sopra, è spalancata. Ma solo il Bambino divino deve uscire per favorire il tranquillo passaggio del ciclo: chiunque esca con lui è un mostro, appunto un lupo mannaro. Se consideriamo le figure del presepe possiamo dividerle in tre gruppi: quelli che camminano, quelli che si muovono sul posto, quelli che sono immobili. Quest'ultimi sono da una parte la sacra famiglia, dall'altra Erode e i suoi uomini. Da una parte, dunque, il buio della grotta che sta per diventare "vera luce", dall'altra lo splendore del castello che si avvia a trasformarsi in "tenebre del passato", del vecchio, del re deposto. L'immobilità della sacra famiglia è propria della perfezione divina, quella di Erode è invece del male assoluto: l'uno e l'altro sono rappresentati proprio dall'assenza di movimento e per opposte ragioni. Il mondo precedente la venuta della luce si trova nell'immobilità del caos, del buio, del paganesimo: la storia si conta alla rovescia. Dopo la comparsa della luce esso deve spostarsi, cambiare, andare verso l'ordine, la luce, il cristianesimo: la storia si conta al diritto. Solo Erode, simbolo del mondo che il cristianesimo si appresta a disgregare, rimane immobile; tutto il resto va verso Gesù e di questo movimento partecipa tutto il cosmo, dalle stelle agli animali agli uomini. I pastori in cammino, in un dato senso simboleggiano il viaggio notturno verso la nuova alba incarnata in Gesù, evocano il passaggio dal paganesimo al cristianesimo, in un altro senso rappresentano i morti che portano doni ai vivi: in particolare il viaggio dei morti verso il Vivo per eccellenza cui fanno omaggio. Il percorso dal buio alla luce, dalla notte al giorno, dalla morte alla vita, dal paganesimo al cristianesimo è interamente riassunto soprattutto nel movimento dei Re Magi verso la grotta. I pastori che si muovono ma non camminano, poi, simboleggiano il ritmo ciclico e circolare; ciò si rappresenta chiaramente nei presepi mobili, dove i movimenti possono essere circolari o verticali, ma ripetono ritmicamente sempre lo stesso tragitto. Il tempo può essere rappresentato anche in altri modi, per esempio con gli effetti di luce nei presepi mobili, che alternano il buio della notte, quando tutti i movimenti dei pastori sono bloccati, alla luce del giorno, che fa riprendere il ritmo del movimento. Queste rappresentazioni del tempo evocano l'incessante ripetizione del ciclo dell'anno e del tempo quotidiano e con questo il ciclo morte-resurrezione che è in esso simboleggiato. Formano dunque lo schema ritmico, il contesto temporale del viaggio, il suo riferirsi ad un "periodo" nel quale avvengono tutte le cose importanti della cultura. Il tessuto simbolico connettivo che articola il presepe è poi il labirinto, già peraltro presente come viaggio attraverso antri, sotterranei, cunicoli, discese, ecc., nelle fiabe, canti, leggende agiografiche, oltre che nel movimento dei pellegrinaggi. Ma è un labirinto inteso in una modalità cristiana, cioè come percorso che conduce con sicurezza alla meta, senza rischi di perdita, purché si segua la luce della cometa verso la "vera luce" della nascita del divino. Eppure, a ben guardare, ogni presepe presenta accanto a questa modalità labirintica per così dire ufficiale, anche una evocazione di mondi e percorsi non illuminati e sicuri, non definiti sufficientemente: gallerie che si perdono nel buio, luoghi laterali non colpiti dalla luce, scorci lontani e indistinti, segni che lasciano immaginare percorsi nascosti, incerti. Un labirinto, insomma, che non si riassume nella certezza della vera fede, ma che conserva l'incertezza di una vita non interamente riscattata o salvata dal male e dal dolore. Visto dall'interno delle tradizioni popolari, il presepe non è solo un evento rituale specifico del Natale, ma è un momento di un percorso simbolico annuale, in cui si richiamano e si riassumono per opposizione, contiguità, slittamenti, tutti i momenti significativi dell'anno rituale arcaico. Infatti, il tema precipuo del presepe, il viaggio, è presente in tutto l'arco annuale della ritualità religiosa popolare. Il ciclo rituale primaverile-estivo si basa proprio su un sistema di pellegrinaggi, cioè di viaggi sacrali. Il pellegrinaggio estivo, con un percorso ampio all'esterno del paese, lontano dalle case, verso un luogo sacro manifesto, corale, aperto, comunitario, corrisponde simmetricamente al pellegrinaggio al presepe, che soprattutto in passato ma anche oggi viene compiuto, come visita al presepe delle chiese, dei parenti, degli amici, dei vicini. In questo caso il viaggio è verso l'interno delle case (o delle chiese), verso gli ambienti intimi, oscuri, chiusi. Il presepe stesso, poi, come abbiamo visto è in sé un percorso verso l'interno, l'intimo, la grotta, il buio, da cui poi nascerà la luce che alimenterà il ciclo successivo e così via, incessantemente. C'è, in effetti, nel periodo primaverile-estivo e in quello autunnale-invernale un doppio movimento ciclico dall'interno verso l'esterno e dall'esterno verso l'interno per ciò che riguarda i luoghi sacri. Questo riflette l'alternanza dei due cicli parziali, che esprime il ritmo notte-giorno, buio-luce, dentro-fuori, sotto-sopra e compone una simmetria conchiusa (ripresa nel rituale) su vari piani: quello del ciclo vegetale, quello degli spazi rituali, quello dello scambio con i morti. Da notare che l'intimità dei "viaggi" invernali, in particolare del presepe, non coincide con il privato. Infatti, la dimensione di "discesa" verso l'interno, il sotterraneo, il buio, richiama la morte, che è con tutta evidenza uno dei fulcri della logica presepiale. Non a caso lo schema tradizionale di rappresentazione vuole che lo sguardo del visitatore si muova dall'alto a sinistra, da dove il pastore dormiente, Benino, introduce con il suo sogno alla discesa verso la grotta. Da novembre in poi i morti vengono sulla terra per portare doni ai vivi: santa Lucia, sant'Aniello, san Nicola, i Re Magi, la Befana, lo stesso Gesù bambino. Simmetricamente i vivi, in primavera e in estate, offrono ai morti sacrifici, primizie e preghiere. Oltre a ciò, il presepe ha una sua densa specificità mitica. Dio crea gli uomini dalla terra, dall'argilla; nel crearli dà loro il gesto archetipo della creazione. Gli uomini, imitandolo, creano figure d'argilla; con esse raccontano la nascita del Dio. Nel presepe è contenuta una potente immagine mitica, che esprime il reciproco della creazione divina, umanizzato e affidato alle mani esperte e sapienti degli artigiani dell'argilla, della ceramica, della terra che si cuoce. Ciò che Dio dà è anche ciò che gli viene dato, il mondo da lui posto è anche il mondo che lo pone. Il presepe è innanzitutto un asse di coincidenza tra il divino e l'umano, di messa in comune, tra l'atto creativo e la sua mimesi.
Paolo Apolito