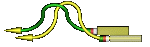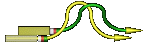A ripensarci ora, quelle figurine in terracotta che animavano i presepi di sughero e carta nelle case dei vietresi, più che a pastori somigliavano ad una corte dei miracoli. Statuine fragili, rifinite approssimativamente che, all'improvviso e al minimo tocco, potevi ritrovare senza un braccio o una gamba Una umanità deforme che giunta davanti alla grotta della Natività, più che rendere omaggio al Redentore sembrava invocare la grazia di ritornare come era prima. E in verità, in un paese che a volte contava quasi più fabbriche di ceramica che case, questi pastori avrebbero meritato ben altra accuratezza nella realizzazione. A renderli così fragili e precari era il modo stesso in cui venivano creati. Cotti in fornaci improvvisate, a volte ospitate negli scantinati, se, miracolosamente, i pastori riuscivano a entrare in una vera fornace, ci arrivavano da clandestini e come tali dovevano adattarsi ad essere collocati nelle zone più a rischio. Una volta decorati, mai e poi mai, avrebbero avuto l'onore di una seconda cottura, come invece era di rigore per la ceramica. E così venivano lasciati con i colori crudi. Il fatto è che ai pastori vietresi non si attribuiva una grande tradizione, anzi, ad essere sinceri, è come se fossero stati i parenti poveri della famosa e celebrata scuola napoletana. Le statuine non avevano alcun mercato. Venivano eseguite dai ceramisti nei momenti di pausa dal lavoro o più frequentemente erano le donne che le realizzavano nelle proprie case. Con l'approssimarsi del Natale i pastori li si smerciava dappertutto. Poteva capitare di vederli nelle drogherie, nelle salumerie, in qualsiasi punto vendita - si direbbe oggi- dove il ceramista riusciva a piazzarli.
 Quella varia rappresentazione dell'umanità, fuori dal contesto presepiale, sembrava avere un atteggiamento tra il meravigliato e l' inebetito; lo stesso che ha dato origine all'espressione dialettale "mi sembri un pastore della meraviglia" rivolta spesso a chi rimane sorpreso dai normali gesti quotidiani.
Eppure, a dispetto della loro fragilità, quei pastori sono riusciti a sopravvivere ad avvenimenti per loro traumatici, quali l'avvento dell'albero di Natale o quelle terrificanti imitazioni, prima in carta pesta poi in plastica, che apparvero alla Standa in quegli anni. A permettere che, in quel periodo,i pastori non scomparissero del tutto, fu il prodigarsi di pochi artigiani, anche per la necessità di arrotondare i magri guadagni.
Forse ad un certo punto e per qualche tempo, rimase addirittura un solo artigiano a realizzarli: Giuseppe Di Mauro detto "Birbone". Vincenzo Procida invece aveva lavorato con il grande Guido Gambone ma aveva conservato l'indole di ceramista popolare e quando ritornò da Firenze, negli anni sessanta, riprese a lavorare con il fratello Giosuè nella fabbrica che era stata dell'altro loro fratello, Salvatore. Con l'approssimarsi delle festività natalizie aveva cominciato a creare piccoli presepi popolati da minuscoli pastori, il tutto in terracotta. Era una cosa fino ad allora mai vista ma, piano piano, nei negozi di ceramica vietresi questi manufatti cominciarono ad essere esposti con sempre maggiore frequenza. Credo che fu per questo motivo che Geppino Cilento, architetto napoletano, incontrò Vincenzo Procida. Questo incontro diede vita a delle forme di presepe, che il tempo ha reso famose e ricercate. Le figure di Maria e Giuseppe di solito erano alte più di trenta
centimetri, mentre tutti gli altri pastori e gli angeli erano invece piccolissimi e abbarbicati al manto dei santi. I presepi erano sempre uno diverso dall'altro. A volte sulle spalle dei protagonisti della natività si sviluppavano a cascata case in miniatura, con il tetto a volta, tipico dell'architettura spontanea della costiera amalfitana. Spesso la base del presepe era costituita da un piatto circolare sul quale venivano realizzati piccoli portacandele, intervallati da animali in miniatura di tutte le specie. Un giorno, nell'ottobre dell''80 mi telefonò Irene Kowaliska, per chiedermi se potevo passare dai fratelli Procida per ordinare quattro presepi per la sua gallerista.
Ne ordinai cinque perché uno lo volevo per me. Chiesi solo se potevano usare uno smalto di base meno lattiginoso di quello che adoperavano normalmente e che fosse quindi più simile a quello della tradizione ceramica vietrese. Giosuè, che era il mastro fornaciaio, mi rispose che non sapeva se la cosa era possibile perché la loro muffola non raggiungeva la temperatura necessaria per la cottura di un altro tipo di smalto e poi la "sacchetta di smalto buono" costava di più. Gli risposi che avrei pagato io la differenza - si trattava di poche migliaia di lire - e che qualsiasi fosse stato il risultato me ne assumevo tutta la responsabilità. Non saprò mai se veramente seguirono il mio consiglio o che tipo di diavoleria combinarono. Fatto sta che quando tornai da loro per vedere se i presepi erano pronti, mi trovai di fronte a cinque opere dai colori intensissimi, che sembravano appena uscite dalle per noi mitiche fornaci a legna, quelle stesse che avevano reso famos
e le ceramiche vietresi negli anni '20. Una meraviglia assoluta e non fu poco il mio imbarazzo nel dover decidere quale prendere. lI presepe che scelsi acquista di anno in anno una patina scura, probabilmente dovuta al fumo delle candele, che lo rende sempre più misterioso e senza età, se non fosse per quell'unico riferimento temporale che mi torna alla mente ad ogni Natale e mi fa ripensare alla bottega dei due fratelli Procida, padri della nuova tradizione presepiale vietrese, quella promossa alla doppia cottura.
Quella varia rappresentazione dell'umanità, fuori dal contesto presepiale, sembrava avere un atteggiamento tra il meravigliato e l' inebetito; lo stesso che ha dato origine all'espressione dialettale "mi sembri un pastore della meraviglia" rivolta spesso a chi rimane sorpreso dai normali gesti quotidiani.
Eppure, a dispetto della loro fragilità, quei pastori sono riusciti a sopravvivere ad avvenimenti per loro traumatici, quali l'avvento dell'albero di Natale o quelle terrificanti imitazioni, prima in carta pesta poi in plastica, che apparvero alla Standa in quegli anni. A permettere che, in quel periodo,i pastori non scomparissero del tutto, fu il prodigarsi di pochi artigiani, anche per la necessità di arrotondare i magri guadagni.
Forse ad un certo punto e per qualche tempo, rimase addirittura un solo artigiano a realizzarli: Giuseppe Di Mauro detto "Birbone". Vincenzo Procida invece aveva lavorato con il grande Guido Gambone ma aveva conservato l'indole di ceramista popolare e quando ritornò da Firenze, negli anni sessanta, riprese a lavorare con il fratello Giosuè nella fabbrica che era stata dell'altro loro fratello, Salvatore. Con l'approssimarsi delle festività natalizie aveva cominciato a creare piccoli presepi popolati da minuscoli pastori, il tutto in terracotta. Era una cosa fino ad allora mai vista ma, piano piano, nei negozi di ceramica vietresi questi manufatti cominciarono ad essere esposti con sempre maggiore frequenza. Credo che fu per questo motivo che Geppino Cilento, architetto napoletano, incontrò Vincenzo Procida. Questo incontro diede vita a delle forme di presepe, che il tempo ha reso famose e ricercate. Le figure di Maria e Giuseppe di solito erano alte più di trenta
centimetri, mentre tutti gli altri pastori e gli angeli erano invece piccolissimi e abbarbicati al manto dei santi. I presepi erano sempre uno diverso dall'altro. A volte sulle spalle dei protagonisti della natività si sviluppavano a cascata case in miniatura, con il tetto a volta, tipico dell'architettura spontanea della costiera amalfitana. Spesso la base del presepe era costituita da un piatto circolare sul quale venivano realizzati piccoli portacandele, intervallati da animali in miniatura di tutte le specie. Un giorno, nell'ottobre dell''80 mi telefonò Irene Kowaliska, per chiedermi se potevo passare dai fratelli Procida per ordinare quattro presepi per la sua gallerista.
Ne ordinai cinque perché uno lo volevo per me. Chiesi solo se potevano usare uno smalto di base meno lattiginoso di quello che adoperavano normalmente e che fosse quindi più simile a quello della tradizione ceramica vietrese. Giosuè, che era il mastro fornaciaio, mi rispose che non sapeva se la cosa era possibile perché la loro muffola non raggiungeva la temperatura necessaria per la cottura di un altro tipo di smalto e poi la "sacchetta di smalto buono" costava di più. Gli risposi che avrei pagato io la differenza - si trattava di poche migliaia di lire - e che qualsiasi fosse stato il risultato me ne assumevo tutta la responsabilità. Non saprò mai se veramente seguirono il mio consiglio o che tipo di diavoleria combinarono. Fatto sta che quando tornai da loro per vedere se i presepi erano pronti, mi trovai di fronte a cinque opere dai colori intensissimi, che sembravano appena uscite dalle per noi mitiche fornaci a legna, quelle stesse che avevano reso famos
e le ceramiche vietresi negli anni '20. Una meraviglia assoluta e non fu poco il mio imbarazzo nel dover decidere quale prendere. lI presepe che scelsi acquista di anno in anno una patina scura, probabilmente dovuta al fumo delle candele, che lo rende sempre più misterioso e senza età, se non fosse per quell'unico riferimento temporale che mi torna alla mente ad ogni Natale e mi fa ripensare alla bottega dei due fratelli Procida, padri della nuova tradizione presepiale vietrese, quella promossa alla doppia cottura.
Pietro Amos